


Per quanti sforzi si siano fatti ben poche notizie si sono trovate di questo nostro illustre cittadino.
Tommaso Vagliasindi si segnala in quanto da socialista assieme ad alcuni membri della famiglia Fisauli nel 1904 si oppone all’on.le Paolo Vagliasindi
e nel suo più famoso libro ” Eresia “ entra in polemica epistolare con Filippo Turati.
Qui di seguito alcune sue pubblicazioni:
– Contro la riscossa feudale : osservazioni intorno alla politica doganale .
Editore : Niccolò Giannotta, 1903 – Catania
– Lavoro e capitale
Editore: N. Giannotta, 1901 – Catania
– Dopo il congresso di Brescia e prima del congresso di Bologna : conferenza : Randazzo, 20 marzo 1904.
Editore: Giannotta, 1904 – Catania
– Avanti! : valzer per pianoforte
Musica a Stampa – Milano : E. Nagas , [18..]
Vagliasindi Tommaso , Turati Filippo
– Eresia? : la bancarotta della lotta di classe ; Appendice: polemica epistolare con Filippo Turati
Editore: N. Giannotta, 1923 – Catania
Se avete delle informazioni per meglio conoscerlo potete inviarle all’indirizzo del sito: info@randazzo.blog oppure al numero whatsApp 3386714473 .

Federico De Roberto
Nacque a Napoli il 16 gennaio 1861, da Federico senior, ex ufficiale di stato maggiore del Regno delle Due Sicilie e dalla nobildonna di origini catanesi, ma nata a Trapani, Marianna Asmundo.[1]
Si trasferì con la famiglia a Catania nel 1870 dopo aver subito giovanissimo la dolorosa perdita del padre, travolto da un treno sui binari della stazione di Piacenza. Da allora, salvo una lunga parentesi milanese e una più breve a Roma, Federico visse all’ombra, gelosa e possessiva, di donna Marianna.[2]
A Catania si iscrisse all’Istituto tecnico “Carlo Gemmellaro”, quindi frequentò il corso di scienze fisiche, matematiche, naturali all’università: ebbe pertanto una prima formazione scientifica, alla quale affiancò presto l’interesse per gli studi classici e letterari, allargando la sua cultura al latino.
Il suo esordio letterario avvenne con il saggio Giosuè Carducci e Mario Rapisardi. Polemica, pubblicato a Catania dall’editore Giannotta nel 1881. Fu presto conosciuto negli ambienti intellettuali per la sua attività di consulente editoriale, critico e giornalista sulle pagine di due settimanali che uscivano a Catania e a Roma: il “Don Chisciotte” e il “Fanfulla della domenica”. Del primo fu anche direttore dal 1881 al 1882; sul secondo scrisse dal 1882 al 1883 sotto lo pseudonimo di Hamlet.
Per l’editore Giannotta fondò la collana di narrativa dei “Semprevivi” ed ebbe modo di conoscere Luigi Capuana e Giovanni Verga con i quali strinse una salda amicizia. Nel 1883 raccolse in un volume dal titolo Arabeschi, tutti i suoi scritti di arte e letteratura e nel 1884 avviò la collaborazione, utilizzando il suo vero nome, con il Fanfulla della domenica, e tale collaborazione durò fino al 1900.
Un momento importante per la formazione dello scrittore fu l’incontro, durante un soggiorno in Sicilia, con Paul Bourget (1852-1935), in quei tempi molto noto per i suoi studi psicologici e per i suoi romanzi, nei quali analizzava minuziosamente le coscienze tentando di giungere ad una “anatomia morale”. Decisivo fu per De Roberto il trasferimento a Milano nel 1888 dove fu introdotto da Verga nella cerchia degli Scapigliati, e conobbe Arrigo Boito, Giuseppe Giacosa e Giovanni Camerana, consolidando sempre più la sua amicizia con lo stesso Verga e Capuana. Nel periodo del suo soggiorno milanese collaborò al “Corriere della Sera” e pubblicò diverse raccolte di novelle e romanzi, fra i quali quello che è considerato il suo capolavoro, I Viceré, nel 1894.

Paolo Vagliasindi in Parlamento ed al Governo fu propugnatore di libertà. Immaturamente troncata l’opera sua nobilissima vivrà nella storia della sua diletta terra.
Nel 1897 ritornò a Catania, dove rimase fino alla morte, salvo brevi viaggi. A Catania ebbe un incarico come bibliotecario e visse sostanzialmente appartato e deluso per l’insuccesso della sua opera narrativa. Mentre questa tacque egli indirizzò il suo lavoro intellettuale alla pubblicistica e alla critica, tra i quali si ricordano gli studi su Giacomo Leopardi e soprattutto su Verga che giudicò sempre un suo maestro.
Dopo la morte – 1905 – dell’onorevole Paolo Vagliasindi del Castello di cui era un grande estimatore ed amico, scrisse l’epitaffio che trovasi all’angolo del corso Umberto I con la via Regina Margherita.
Nel 1909 presso l’ Istituto Italiano D’Arti Grafiche – Editore pubblicò ” RANDAZZO E LA VALLE DELL’ALCANTARA ” con 147 illustrazioni e I tavola ( vedi galleria delle foto).
Nel 1915, allo scoppio della prima guerra mondiale fu interventista.
Alla morte del Verga nel 1922 De Roberto riordinò in modo accurato le opere del grande scrittore ed iniziò uno studio biografico e critico che però rimase interrotto per la sua prematura morte avvenuta a Catania per un attacco di flebite il 26 luglio 1927. Perfino in punto di morte De Roberto non ebbe adeguata considerazione, poiché la sua scomparsa fu oscurata da quella immediatamente successiva (27 luglio) di Matilde Serao.
Sostenitore convinto della poetica naturalista e verista, De Roberto ne applicò rigorosamente i termini, portando alle estreme conseguenze quegli aspetti di impersonalità del narratore e di osservazione rigorosa dei fatti.
Le tecniche narrative di De Roberto sono funzionali alla narrazione impersonale ma diverse da quelle di Verga. Innanzi tutto non è presente la regressione della voce narrante nella realtà rappresentata, è presente invece, come nel Mastro-don Gesualdo, il discorso indiretto libero ma in larga misura la narrazione si fonda sul dialogo e sulla presenza di didascalie descrittive. La narrazione tende a far propria la tecnica teatrale; nella Prefazione ai Processi verbali De Roberto afferma: «L’impersonalità assoluta non può conseguirsi che nel puro dialogo, e l’ideale della rappresentazione obiettiva consiste nella scena come si scrive per il teatro».
Libri di Federico De Roberto
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Un bel articolo di Giuseppe Giglio su Federico De Roberto.
La razza dei Viceré
«La storia è una monotona ripetizione: gli uomini sono stati, sono, e saranno sempre gli stessi», mormora il principe Consalvo Uzeda di Francalanza all’arcigna zia Ferdinanda (un’irredimibile usuraia), in chiusura de I Viceré, il capolavoro che Federico De Roberto licenziò nel 1894, anticipando tanta letteratura europea che avrebbe raccontato il Novecento: quel secolo inquieto e feroce che è cominciato nell’Ottocento, e che ancora non è finito.
E con I Viceré il grande scrittore siciliano continuava e rafforzava la linea (aperta dal Verga disincantato de I Malavoglia, nel 1881: laddove la Sicilia di una povera famiglia di pescatori dava corpo e sangue allo scandalo della mancata modernizzazione di uno Stato sempre latitante, salvo che per la leva e le tasse) di quella sorta di contro-storia d’Italia che, dopo De Roberto, avrebbe trovato i suoi cantori in Pirandello, Brancati, Tomasi di Lampedusa, fino a Consolo e Sciascia.
Una contro-storia dalle diverse intonazioni, ma sempre più tangibile, più luminosa, più vera di tanta realtà spesso oscura, se non inconoscibile: nel segno di quelle verità del vivere (pubblico e privato) che, attraverso la letteratura, alla vita stessa ritornano.
De Roberto narra le vicende di un’antica, nobile e potentissima famiglia catanese, gli Uzeda di Francalanza, di origini spagnole, in un arco temporale che va dal 1855 al 1882, quasi in presa diretta: dalla fine del dominio borbonico alle prime elezioni a suffragio allargato del nuovo Regno unito.
Una storia genealogica (di una genealogia aperta, che sempre trova nuova linfa, nella sua immutabilità) dentro la storia siciliana e italiana, e che si apre con la morte e i funerali della principessa Teresa, la dispotica decana di casa Uzeda.
Una che «sapeva leggere soltanto nel libro delle devozioni e in quello dei conti», e il cui testamento reca i segni inequivocabili di una volontà di dominio economico, di una sete di potere che si mutano in destino.
Un personaggio centrale, dominante, quello della principessa Teresa; presente proprio perché assente, paradossalmente. E la sua morte, i suoi funerali, già prima del loro apparire sulla scena, offrono un accesso immediato ad un singolare teatro di umanità: dove dal frenetico chiacchiericcio dei vari subalterni (cocchieri, famigli, affittuari…) – prima ancora che da quello dei parenti o delle autorità civili ed ecclesiastiche – prendono forma le fattezze dei vari Uzeda.
Ed eccoli, gli esemplari di quella razza padrona e capricciosa, ignorante e spregiudicata: il principe Giacomo (il primogenito della principessa Teresa), che impugna e modifica il testamento materno, ricatta gli altri eredi, si mette contro il fratello, il contino Raimondo; il quale dal canto suo dissipa il patrimonio, perseguita la moglie (impostagli dalla madre) e sposa l’amante.
E ancora, gli altri figli della principessa Teresa: Lodovico, che (obbligato al convento) si dedica cinicamente alla carriera ecclesiastica; Ferdinando, con le sue fissazioni che finiscono per scivolare nella follia; Chiara, la cui ossessione di maternità si spegne in un parto mostruoso; Lucrezia, che sposa un ricco avvocato, il quale cura le speculazioni degli Uzeda, ricevendone però solo delusioni.
E poi i fratelli della principessa Teresa: don Blasco (costretto a farsi frate, litigioso e donnaiolo), che da ferocemente borbonico fa presto a convertirsi alle idee del nuovo Regno, coniugando gli affari col potere (ridotto allo stato laicale, dopo la soppressione di tante istituzioni religiose, accumula una consistente fortuna speculando sui beni di provenienza conventuale e sui titoli di stato); come suo fratello, il duca di Oragua, che riesce a spacciarsi per liberale e a farsi eleggere deputato del Regno, a dar corso ad un suo emblematico convincimento: «Ora che l’Italia è fatta, dobbiamo fare gli affari nostri».
Per arrivare a Consalvo, il figlio del principe Giacomo: che rinnova le tradizioni di famiglia, da abilissimo stratega della finzione e del tradimento, diventando anch’egli deputato. E dando così voce ad una feroce ideologia del potere, della conservazione del potere: cristallizzata, quell’ideologia, nel famoso comizio (un distillato di micidiale retorica) che il rampollo degli Uzeda tiene davanti ad un vasto pubblico, e che gli spalanca le porte del parlamento di un’Italia oramai unita, ma tutt’altro che nuova.
La principessa Teresa e Consalvo, dunque. Che aprono e chiudono il romanzo, rispettivamente; e che ne portano tutto il senso, l’attualità sempre viva. E sono anche, nonna e nipote, nel loro pensare e agire, spie di una feudalità antica, storica, e di una feudalità familiare. E queste feudalità finiscono per coincidere, così rinnovandosi; ma sempre mimetizzandosi, sempre rimanendo nascoste, come se ogni volta trovassero nuovi canali carsici.
E se De Roberto è lo scrittore della disperazione nella Storia (diceva Sciascia), se I Viceré è un romanzo antistorico, un processo alla storia di delusioni e nequizie (la mistificazione risorgimentale, il trasformismo, il conformismo, la demagogia, il cambiare tutto perché nulla cambi, quella mistificante retorica che avrebbe alimentato le illusioni patriottiche e coloniali, fino al fascismo, e che si sarebbe ritrovata, riscoperta nell’Italia delle mafie, delle stragi, dei misteri irrisolti); se è, la saga degli Uzeda, anche una lucida e spietata inquisizione del presente; se I Viceré è insomma tutto questo, l’abilissima invisibilità di De Roberto tra i suoi personaggi, tra le loro storie (che sono soprattutto il racconto di un modo di essere, di stare al mondo; che danno consistenza, soprattutto, ad uno strisciante utilitarismo), svela invece la felicità della scrittura del grande narratore.
Già in apertura di romanzo, laddove De Roberto illumina il lato oscuro, egolatrico, di quella sorta di religione della famiglia che Verga aveva celebrato nei Malavoglia.
Dissacrandola, alla fine, quella religione: i valori di Padron ‘Ntoni e famiglia diventano disvalori con gli Uzeda, con quella razza avida, che vive nell’ossessione del potere e del sesso.
Una razza i cui membri sono spesso in guerra tra loro, ma sempre si ritrovano uniti nel perseguire e rafforzare il potere della famiglia, a favorirne l’ascesa.
Un familismo eletto a vero e proprio sistema di vita, che De Roberto – da rigoroso anatomopatologo qual è – consegna al lettore. Insieme ad una società che dovrebbe essere nuova, e che invece nuova non è, e che non è neanche una società: dove non di rado è l’inautenticità a regolare i rapporti umani, a dettare le regole dell’esistenza.
«Un’opera pesante, che non illumina l’intelletto come non fa mai battere il cuore», aveva chiosato Benedetto Croce a proposito de I Viceré. Per nulla accorgendosi della luce di quel grande romanzo, ovvero della capacità che esso ha di illuminare l’intelletto, e di sollecitare il cuore.
Semplicemente parlando dell’uomo, del mondo. Semplicemente mostrando alcune pagine – tra le più lucidamente fosche, tra le più goyesche – di quella negatività, di quel male che della vita, del mondo, dell’uomo sono parte integrante e ineludibile.
Sempre. «No, la nostra razza non è degenere: è sempre la stessa», dice Consalvo alla zia Ferdinanda, alla fine. Ed è, la luce de I Viceré, potentemente corrosiva e demistificatoria.

Giuseppe Giglio
Giuseppe Giglio vive a Randazzo (CT). È un giovane critico letterario. Si occupa soprattutto di letteratura del Novecento, nel segno di un’idea di critica letteraria come critica della vita.
Ha pubblicato articoli e saggi su periodici letterari e quotidiani come “Stilos”, “Polimnia”, “Pagine dal Sud”, “l’immaginazione”, “Il Riformista”.È tra gli autori del volume miscellaneo Leonardo Sciascia e la giovane critica, uscito nel 2009 presso Salvatore Sciascia Editore.
Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2010, I piaceri della conversazione.
Da Montaigne a Sciascia: appunti su un genere antico. Con questo libro ha vinto il premio “Tarquinia-Cardarelli” 2010 per l’opera prima di critica letteraria.
È una delle firme de “Le Fate”, una nuova rivista siciliana di arte, musica e letteratura. Scrive su “Fuori Asse”, una rivista letteraria torinese on-line. Fa parte della redazione di “Narrazioni. Rivista quadrimestrale di autori, libri ed eterotopie”, un periodico nato nel Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Scienze Storiche e Sociali dell’università di Bari, ma fatto da giovani critici non strutturati, e con l’ambizione di porsi come un osservatorio sul romanzo contemporaneo. Scrive anche sulle pagine della cultura del quotidiano “La Sicilia”.
Guardare e (ri) scoprire la Sicilia attraverso gli scatti di De Roberto
É a Randazzo, secondo Leonardo Sciascia, che lo scrittore emerge come fotografo.
Qui coglie la prospettiva delle vie «che delineano questo paese nell’altura», come nello scatto delle case di via Furnari, la Volta di via degli Uffizi o la Porta Aragonese.
Tra i seminari organizzati per la decima edizione del Med Photo Fest 2018, Rosalba Galvagno, docente di critica letteraria e letterature comparate presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, ha ricostruito un itinerario in Sicilia attraverso lo sguardo di Federico De Roberto, nelle vesti non solo di scrittore ma anche di fotografo, come testimoniano gli scatti presenti nella guida della città di Randazzo e la Valle dell’Alcantara pubblicata nel 1909.
Lo scrittore si avvicina alla fotografia all’incirca all’età di vent’anni con una «tecnica che trasformava in continuazione lastre ed obiettivi».
A causa della guerra e del bombardamento che distrusse il palazzo presente tra la via Etnea e la via Sant’Euplio, dimora catanese dello scrittore, nessun originale è giunto a noi. Quel che però emerge dalle poche immagini è che «poneva attenzione per realizzare servizi fotografici perfetti»
.
Nell’articolo “San Silvestro da Troina” pubblicato nell’agosto del 1908 su “Lettura”, mensile illustrato del Corriere della Sera, De Roberto «rivive con le parole quello che si trova nelle immagini»: l’evento della processione, un tema amato, presente anche in “Randazzo” e ne “I Viceré”, che rientra nei servizi di cronaca mondana di cui si era occupato da fotoreporter.
Dalle lettere inviate a Corrado Ricci emerge il suo interesse per la Sicilia e i suoi luoghi, dalle città ai castelli etnei, alle isole Eolie che definisce «isole di Dio».
Un’attività che unisce riproduzione fotografica e retorica, in cui il lettore viene guidato attraverso uno sguardo storico, estetico e poetico. De Roberto fotografa palazzi, balconi, coglie il senso della connotazione fisica dei luoghi, oggetti su cui si documenta accuratamente prima degli scatti.
É a Randazzo, secondo Sciascia, che De Roberto emerge come fotografo.
Qui coglie la prospettiva delle vie «che delineano questo paese nell’altura», come nello scatto delle case di via Furnari, la Volta di via degli Uffizi o la Porta Aragonese. Fotografa la Festa dell’Assunta, il campanile di San Martino, le Balze di San Domenico, le finestre, come quelle di via Granatara, aperture da cui si affacciavano i sovrani che passavano da Randazzo, una città ricca di elementi storici, di cui De Roberto prova a catturare l’atmosfera storica e medievale.
Ne emerge un itinerario siciliano che ha suscitato nella maggior parte dei presenti la curiosità di visitare, o rivisitare, la città di Randazzo, magari scattando qualche fotografia.
Le relazioni nascoste di Federico De Roberto
di Antonino Cangemi
La vita di Federico De Roberto non fu certamente facile; né facile fu il suo rapporto con le donne. Afflitto da frequenti stati depressivi, che lo debilitavano anche fisicamente e ne spegnevano gli entusiasmi, alternati a momenti di vitalità e di euforia, oggi De Roberto sarebbe definito un “bipolare”. Le relazioni col “gentil sesso” furono condizionate, oltre che dagli ondivaghi moti dell’umore, dalla presenza di una madre possessiva e invadente, Marianna Asmundo Ferrara. Tuttavia, nell’esistenza turbolenta e avara di felicità dell’autore de I viceré, non mancarono amori “clandestini”.
Ricerche recenti sull’epistolario di De Roberto conservato presso la Biblioteca Universitaria di Catania mettono in luce la relazione segreta tra De Roberto ed Ernesta Valle. Ne apprendiamo i particolari grazie al minuzioso lavoro di Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla che hanno curato Si dubita sempre delle cose più belle. Parole d’amore e di letteratura, un libro poderoso (2144 pagine, 764 lettere, tantissime immagini a corredo) edito da Bompiani (2014) che, riscoprendo il carteggio tra i due amanti, getta squarci sulla complessa figura di De Roberto, sul suo problematico rapporto con le donne, sulle sue ambizioni letterarie e giornalistiche soffocate a Catania e proiettate su Milano.
Federico De Roberto conosce Ernesta Valle nel salotto milanese di casa Borromeo. Un salotto meta dei più acclamati scrittori, giornalisti, editori dell’epoca: lo bazzicano personalità dal rilievo di Eugenio Torelli Viollier, Luigi Albertini, Domenico Oliva, Giuseppe Giacosa, Ugo Ojetti, Arrigo Boito, Emilio e Giuseppe Treves. È il 29 maggio del 1897, De Roberto ha trentasei anni, ha già pubblicato quello che si rivelerà essere il suo capolavoro, I vicerè, e a Milano cerca di affermarsi nel mondo del giornalismo (un contratto di collaborazione lo lega ad Albertini e al suo Corriere) e di frequentare i protagonisti dell’editoria e della cultura, letteraria e artistica. Nella mondanità meneghina quel siciliano talentuoso e ambizioso, qual è Federico De Roberto, non passa inosservato: i suoi eclatanti baffi a manubrio accompagnati dall’immancabile monocolo adagiato sull’occhio destro gli hanno fatto conquistare l’appellativo scherzoso di “Lord Caramella”.
Ernesta Valle è sposata con l’avvocato messinese Guido Ribera, ha ventun anni, un bambino di cinque anni da accudire, e allo splendore della giovinezza unisce l’eleganza di chi è avvezza alla vita mondana. Ernesta si fregia del titolo di contessa (non si sa bene quanto autentico), è nata nel 1876 a Ventimiglia, da Giuseppe Valle, un impiegato di Valle Lomellina, e da Adelaide Corradi. Avvenenza, femminilità, savoir-faire e un buon matrimonio le hanno spianato la strada introducendola nella borghesia notabile della Milano del tempo.
L’incontro con Ernesta Valle per Federico De Roberto è un colpo di fulmine. Tanto da scrivere: ‹‹Da quel giorno, voglio dire da quella sera, cominciò la mia felicità››. Da quella sera di maggio esplode la sua passione. Che genera un profluvio di lettere: palpitanti, focose, ardenti; ma anche rivelatrici di ambizioni e stati d’animo e con più di un richiamo alla letteratura. Come si conviene in ogni storia d’amore i due amanti si chiamano tra di loro con uno o più vezzeggiativi. Per De Roberto Ernesta Valle è Renata, a simboleggiarne la rinascita all’amore e nell’amore, ma anche Nuccia, diminutivo di “femminuccia”, perché in lei risiede la quintessenza di una femminilità prospera e procace; per Ernesta Valle De Roberto è Rico, la parte finale del suo nome di battesimo.
Nel suo spostarsi tra Milano e Catania Rico tiene sempre vivo il legame con Renata grazie a una corrispondenza fitta, accesa e meticolosa. Che talvolta trabocca di carica erotica: ‹‹Tutta nuda nell’anima come l’ho vista e tenuta e baciata e bevuta e goduta tutta nuda nel corpo adorato e divino›› (i due passeranno al tu dopo cinque mesi), in una prosa da romanzi rosa d’appendice che lo scrittore avrebbe aborrito: ‹‹Mi pare che sia tuo il sangue che mi scorre nelle vene, non ho più personalità››. Altre volte rivela abbandoni sentimentali e richiami a un amore sublimato nella sua purezza con un eccesso di enfasi che sbalordirebbe se non si pensasse che a vergare quelle frasi sia un uomo innamorato: ‹‹O Cuor dei cuori, quando tu mi dici di partire il moto della mia obbedienza è così pronto che io vorrei già essere sotto un altro cielo››. Altre volte ancora le lettere fanno da cronaca alle tappe dei loro incontri, con puntualità ossessiva, illustrando i luoghi dei furtivi appuntamenti: via Romagnosi, dove ha sede il salotto che li ha fatti conoscere, via Jacini, via Pietro Verri, Porta Volta, Crescenzago, i caffè, i teatri, soprattutto la Scala.
Le lettere di Rico e Renata, tuttavia, non danno sfogo solo a desideri carnali (vivissimi nello scrittore), a spinte erotiche e a sentimentalismi vari, ma palesano anche intese su argomenti letterari e De Roberto si prodiga a consigliare all’amante le migliori letture: ‹‹Ti ho mandato altri libri. Non so quali sono quelli che tu non conosci, tra quanti ne posseggo. Desideri leggere altre novelle di Maupassant? Io le ho tutte. Ho tutto Zola: dimmi se qualche cosa di lui ti riesce nuova. E di Daudet? E dei Goncourt? Conosci i famosi romanzi russi: La Guerra e la Pace di Tolstoj; Anna Karenina pure di Tolstoj; il Delitto e il Castigo di Dostoevskij? Vuoi qualche cosa di Giorge Sand, di Balzac? Conosci le novelle fantastiche di Poe? Aspetto, per la prossima spedizione, che tu mi dica delle tue preferenze›› (Catania, 6 gennaio 1898). Rico le fa leggere pure alcune sue opere, tra queste I vicerè la cui protagonista si chiama, guarda caso, Renata e che provoca nell’amante moti di gelosia. Ernesta Renata gli scrive: ‹‹Si può essere anche gelosi del passato››.
Un amore segreto quello tra Rico e Renata, un uomo incapace di ribellarsi alla tirannia edipica della madre, e una donna legata al marito e agli agi della vita salottiera che le è concessa. E come nelle relazioni nascoste i due amanti conoscono mille sotterfugi per scambiarsi le lettere, a mano o in fermo posta, talvolta custodite dentro libri, altre precedute da avvertimenti in codice.
Ma tra i due amanti si avvertono le presenze delle persone a cui sono legate: la madre per Rico, il marito per Renata. Presenze forti, ingombranti, determinanti. Gli escamotage studiati e provati a garanzia della clandestinità della loro relazione hanno effetto? Nulla sanno o percepiscono di quel rapporto donna Marianna Asmundo Ferrara e Guido Ribera? Pare proprio che, malgrado tutte le strategie di occultamento messe in atto dai due amanti, l’eco della loro passione per un verso o per l’altro gli giunga. Tant’è che la madre padrona, ‹‹un bene che mi soffoca e mi strozza››, riesce a far battere in ritirata il figlio in preda all’ardore amoroso. La madre gli scrive lamentandosi della lontananza e invitandolo (anzi intimandolo) a tornare a Catania, ‹‹perché è già molto tempo che sei fuori casa, perché viene l’inverno e tu sai che d’inverno ho bisogno di compagnia››. E l’avvocato Ribera compare pure nell’epistolario con missive assai prosaiche: raccomandazioni da rivolgere all’editore Treves, richieste di prestiti.
Ubbidiente al richiamo della madre, De Roberto ritorna a Catania. La città dell’Etna, nel raffronto con la febbrile e mondana Milano, gli appare in tutta la sua angustia, pigra e sonnolenta, prigione della sua anima esacerbata e soffocata nel suo male oscuro: ‹‹È una malattia morale e non lieve – scrive all’amante riferendosi al suo spleen – Mi sento troppo vuoto, troppo contrariato, troppo sbalestrato, troppo avvilito››. Adesso la lontananza fisica di Renata accentua in Rico il desiderio di intimità con lei e l’inchiostro della scrittura cerca di suggellare e far rivivere i momenti di passione vissuti insieme.
Lettera di Federico De Roberto a Renata (19 Marzo 1899)
De Roberto (Rico) continuerà a scrivere alla Valle (Renata) confidandole i suoi progetti letterari. Renata pare assurgere in certi momenti a “musa” ispiratrice. A lei nel 1899, due anni dopo averla conosciuta, aveva dedicato la prefazione de Gli amori: in modo velato, indicando solo le sue iniziali ‹‹a R.V.››; accorgimento che però non era servito ad aggirare la gelosia del marito che in una lettera gli volle ironicamente precisare che R.V. era la signora Ribera-Valle. A Renata si rivolgerà dopo, tra il 1900 e il 1902, per confidarle i suoi progetti di scrittura. Si era già confrontato con l’amante per il romanzo drammatico Spasimo, accogliendo i suoi suggerimenti di rendere quel testo ‹‹troppo pensato›› più ‹‹parlato››, e riconoscendole il merito di averlo spronato nello scriverlo in uno adattamento ‹‹più rapido e movimentato››. A Renata confesserà il suo proposito di chiudere la trilogia degli Uzeda, inaugurata con l’Illusione nel 1891 e proseguita con I vicerè nel 1892, con L’Imperio, che non farà in tempo a pubblicare e che uscirà postumo nel 1925. A proposito de L’Imperio Rico scriverà a Renata, il 3 giugno del 1902, una lettera piena di sconforto: ‹‹Ho preso pure il manoscritto del romanzo che doveva far seguito ai Vicerè… Faccio questo tentativo di ritorno all’arte senza fede e senza neppure altra speranza che quella di ricavare, chi sa quando, un migliaio di lire del lavoro di chi sa quanto tempo. È questa è la mia vita, propriamente degna d’essere strozzata con tutt’e due le mani, se non fosse il ricordo, la visione, il pensiero e la speranza di Nuccia››. Già, quando De Roberto scrive quella lettera, la relazione con Ren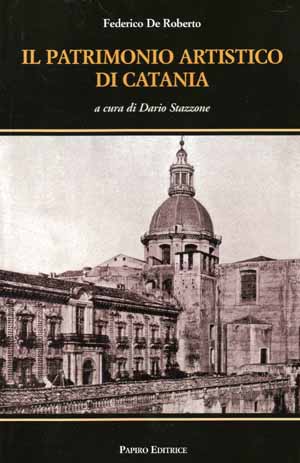 ata volge al declino, come testimonia il carteggio tra i due amanti che copre un arco di tempo racchiuso tra il 1897 e il 1902, con qualche appendice sino al 1916.
ata volge al declino, come testimonia il carteggio tra i due amanti che copre un arco di tempo racchiuso tra il 1897 e il 1902, con qualche appendice sino al 1916.
De Roberto è chiuso nella sua malinconica angoscia, mitigata ma non scalfita dal ricordo di un amore lontano, nello spazio e nel tempo, in una città, Catania, che non ama e che anzi definisce ‹‹l’odiato e aborrito paese››. Passeranno altri anni e il cuore dello scrittore catanese s’invaghirà di un’altra donna, anche lei sposata e legata a una grande città, questa volta Roma. L’ennesimo tentativo di evadere da una Catania per lui claustrofobica? La donna si chiama Pia Vigada, e con lei De Roberto intrattiene un carteggio amoroso che va dal 1909 al 1013. Malgrado il peso degli anni, anche in questo epistolario De Roberto, considerato per alcuni suoi scritti “misogino”, si conferma amante focoso e veemente, e non privo di tenerezze. Un gesto di tenerezza è, ad esempio, quello, in lui usuale, di inviare all’amata dolci tipici di Sicilia e agrumi. Ma De Roberto è anche un uomo geloso, sino al parossismo, in preda a una spiccata sensualità. Come dimostra questo singolare passo di una lettera a Pia Vigada: ‹‹Spiegami che il tuo corpo, le tue forme, la tua carne sono chiuse ermeticamente. E che solo un giorno le tue mani febbrili potranno dischiudere cotanto tesoro…››.
Ma torniamo alla storia di Rico e di Renata che, stando al carteggio di cui oggi si dispone, pare sia macchiata da un epilogo tutt’altro che romantico. Nel 1916, quando la corrispondenza tra i due si è da tempo interrotta e il silenzio ha ormai sepolto un amore ricco di illusioni e di speranze svanite, Renata torna a farsi viva con una lettera di inaspettata aridità e ineffabile opportunismo. In essa l’amante di un tempo implora Rico di versarle una congrua somma di denaro per sollevare il figlio da non ben precisati problemi economici. In realtà, pare che dietro quella cinica richiesta si nasconda una squallida vicenda di corruzione legata (siamo negli anni del primo conflitto bellico) al tentativo di tenere il figlio lontano dal fronte.
Si chiude così, con un finale amaro e beffardo, la storia d’amore che più coinvolse Federico De Roberto. La cui immagine ci torna alla mente nel ritratto che di lui scolpisce la penna di Vitaliano Brancati: un uomo sempre solo, a spasso per la via Etnea con la sua inguaribile angoscia, chiuso dentro la sua ‹‹pesante armatura di onestà››.
Dialoghi Mediterranei, n. 15, settembre 2015
__________________________________________________________
 Loading...
Loading...


Paolo Vagliasindi Polizzi, fu l’uomo cui si deve l’esistenza del Museo archeologico di Randazzo.
Nato nel 1838, e nipote dell’omonimo abate Paolo Vagliasindi, storico e confutatore delle tesi del Plumari, pur non essendo un “esperto”, era tuttavia un appassionato dell’arte e dell’antichità classica, mente aperta e uomo di grande generosità. Per merito suo infatti fu possibile il riscatto del Convento dei Cappuccini, che nel 1866 era stato incamerato dallo Stato a seguito delle legge per la soppressione delle corporazioni religiose. Quando i beni ecclesiastici furono messi all’incanto, il Vagliasindi riacquistò il Convento per restituirlo successivamente all’Ordine.

Paolo Vagliasindi
Ma Paolo Vagliasindi rifiutò fermamente ogni offerta, soprattutto per la cessione del bellissimo e raro oinochoe, vaso per la mescita del vino in terracotta, decorato in rosso su fondo nero, e raffigurante il mito dei Boreadi, perché volle fortemente che la collezione restasse a Randazzo. Anzi, destinò alla raccolta una sala del suo palazzo, rendendola fruibile ai visitatori. Nel 1904 la collezione Vagliasindi fu esaminata e catalogata dal professor Giulio Emanuele Rizzo, Ispettore del Museo nazionale di Roma, che relazionò poi in una breve pubblicazione.
Alla morte di Paolo Vagliasindi, nel 1913, la collezione rimase affidata al figlio Vincenzo, ma fu seriamente danneggiata dai bombardamenti del 1943, che squarciarono il palazzo; molti pezzi andarono distrutti o saccheggiati, altri furono recuperati dai Padri Cappuccini dei vicino Convento, per essere esposti negli anni ’60 in una sede provvisoria presso la Casa di riposo di Randazzo. Solo nel 1998, restaurati e catalogati, hanno trovato degna dimora nel Castello di S. Martino.
Ma il suo nome è rimasto legato alla storia di Randazzo a seguito di un episodio fortuito, che sembra quasi leggendario: tutto cominciò, quando una contadina, prestando il suo lavoro nel feudo di S. Anastasia, proprietà di Paolo Vagliasindi a circa 6 km da Randazzo, s’imbatté casualmente in un piccolo oggetto d’oreficeria, che corse a consegnare al proprietario del fondo. Egli intuendone l’origine, intraprese una prima serie di scavi, in concomitanza con i lavori colturali, e vide materializzarsi poco a poco una vera e propria necropoli.
Una volta sparsa la voce, la Direzione delle Antichità di Palermo prese contatti col Vagliasindi, e furono condotte delle regolari campagne di scavi nel territorio di S.Anastasia e Mischi, dirette nel 1889 dal Salinas e vent’anni dopo da Paolo Orsi: vennero alla luce altre tombe e corredi funerari, monete, vasi, anfore, utensili, gioielli, statuette, ascrivibili al IV-V sec. a.C. In base alle norme vigenti, però, la stragrande maggioranza dei reperti dovettero essere ceduti al Museo Nazionale di Palermo e a quello Archeologico di Siracusa.(M.D.)
 Castello Svevo |
 |