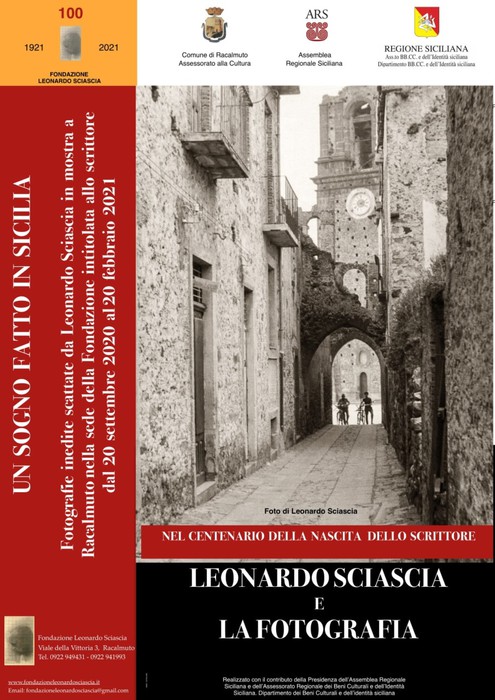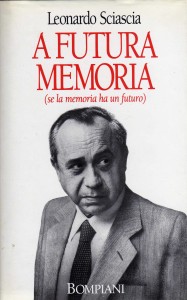Insegnante alle elementari. Questo è Leonardo Sciascia. A chi cerimoniosamente lo appella “maestro!”, da sornione qual è, risponde: “Ebbene sì; maestro di scuola io sono”.
Diplomato alle magistrali dove insegna Vitaliano Brancati, all’istituto IX Maggio di Caltanissetta – la cittadina siciliana d’entroterra della sua più completa felicità – Sciascia, nato cent’anni fa l’8 gennaio 1921, è il pezzo raro della letteratura europea in ragione della sua unicità: essere davvero un intellettuale e, al contempo, un formidabile artista.
A dispetto dei tanti imbonitori di pistolotti moralistici da festival letterari, Sciascia attraversa il suo tempo accompagnando Sandro Attanasio, l’ispettore di Einaudi che alla guida di una Bianchina furgonata vende libri nei più remoti paesi dell’entroterra di Sicilia.
Anni dopo – portando con sé Gesualdo Bufalino – accompagnerà anche Gianni Giuffrida e Mario Andreose per Bompiani mentre con Elvira Sellerio, dagli uffici di via Siracusa a Palermo, inventa la stagione in assoluto più entusiasmante dell’editoria.
Donna Elvira è una vera “comandiera”. Con lei Sciascia affina il dovere sociale e civile della letteratura, inventa la collana della Memoria, fabbrica l’immaginario di libertà a uso di un’Italia bisognosa sempre più di verità nel diritto e della razionalità fuori dall’ideologia dominante e si ritrova “eretico” rispetto alle tante chiese.
Litiga, infatti, con Renato Guttuso, titolare del mistero comunista; in tema di terrorismo polemizza con Italo Calvino che è potente idolo della Cultura col C maiuscolo; si butta alle spalle l’esperienza di consigliere comunale del Pci a Palermo, quella di parlamentare radicale al fianco di Marco Pannella e dopo aver votato la lista del Garofano, scrive – ma senza iscriversi al partito – a Bettino Craxi.
Col leader del Psi, inviso a tutte le anime belle, Sciascia consuma il trauma definitivo presso il ceto dei colti e sulla questione dolente della giustizia – col simbolo della bilancia ormai sostituito con quello delle manette – rompe l’andazzo forcaiolo al punto di essere
tratteggiato da Giorgio Bocca al pari di un avvocaticchio; con la paglietta e l’abito bianco dei Don.
Bocca che riteneva l’Inferno un vasto Sud abitato da diavoli raccontava dunque l’autore de Il Giorno della civetta vestito al modo di una macchietta. E lo vedeva perfino “immerso nei ragionamenti mafiosi”. Antonio Di Grado, già presidente della Fondazione Sciascia, non ha mai dimenticato questo inciampo di Bocca, ma gli è che la Buonanima nei suoi viaggi in Italia cercava solo ciò che voleva trovare, al punto d’inventarsi – in un rigurgito razzista – uno Sciascia con la coppola.
È quello che sul Corriere della Sera pubblica il fondamentale editoriale dal titolo “I Professionisti dell’Antimafia” e la milizia di Leoluca Orlando, il comitato antimafia, sfregia ponendolo addirittura “ai margini della società civile”.
A proposito di coppole, di zii di Sicilia – e d’incontri pericolosi – sembra un racconto di Sciascia l’incontro del Maestro di Regalpetra con Marcello dell’Utri, nientemeno.
In un pomeriggio del 1983 a Milano, il non ancora senatore di Forza Italia si aggira tra gli scaffali quando il proprietario, coccolandolo come merita un cliente spendaccione, gli dice: “Di là c’è Sciascia, lo vuole conoscere?”. Imbarazzato, Dell’Utri dice sì “ma” – si premura ad aggiungere – “non voglio disturbarlo”.
Il libraio fa allora le presentazioni, Sciascia è altrettanto imbarazzato nel far un minimo di conversazione con uno sconosciuto, porge timidamente la mano ma il libraio, molesto assai, dice al maestro: “Questo signore è il dottor Dell’Utri, il braccio destro del dottor Berlusconi…”.
Con un’espressione muta che il palermitano Dell’Utri decifra benissimo, Sciascia si sta interrogando – “e cu è?” – mentre il libraio, inesorabile, continua: “Quello di Canale5!”.
L’illustre letterato in un sussulto rimedia alla gaffe: “Certo, certo, la guardiamo questa televisione”. Il libraio, soddisfatto di avere trovato almeno quest’appiglio prende la copia di Cruciverba, un libro edito dalla Einaudi, e lo porge a Sciascia chiedendogli una dedica per il dottor Dell’Utri. “E cosa scrivo?” domanda lo scrittore facendo una faccia sconfortata ed è lo stesso Dell’Utri a soccorrerlo in quel frangente: “Manco mi conosce, non si può sbilanciare; scriva ‘cordialmente, senza cordialità’; e così non sbaglia”.
La battuta piace così tanto a Sciascia da fargli accendere la parlantina e allo sconosciuto avventore incontrato in libreria racconta di quando, nel 1958, da giovane maestro alle elementari – pur distaccato a Roma al ministero, corrispondente da Caltanissetta per L’Europeo – è incaricato di intervistare Genco Russo, il capo della mafia.
Sciascia si adopera con l’avvocato di Genco Russo per organizzare l’incontro a Mussomeli e così fare l’intervista. Il servizio va a buon fine ma quando sta per prendere congedo dai due ecco che l’avvocato porge a Sciascia una copia fresca di stampa de Gli zii di Sicilia e gli dice: “Firmaci una dedica allo zio Genco”.
Tutto poteva immaginare, Sciascia, eccetto che ritrovarsi a fare una dedica a Genco Russo. Il dio del genio e dell’improvvisazione però gli viene in aiuto. E così scrive: “Allo zio di Sicilia, questo libro contro tutti gli zii”.
In tema di “sicilianizzazione” – il progressivo degrado di una povera nazione qual è l’Italia – nel Giorno della Civetta, uno tra i suoi libri più famosi, Sciascia introduce una efficace locuzione: la linea della palma, emblema della prossimità desertica che come il mercurio di un termometro segnala l’immobilità sociale.
Preso a prestito e a pretesto di cavoli a merenda, con lo sciascismo fuori luogo rispetto alla sua stessa poetica – tutta di asciuttezza e rigore – perfino Sciascia è diventato un genere orecchiato ora in un tribunale, ora in una redazione o, peggio ancora, nelle chiacchiere da talk.
Tra le botole dei luoghi comuni, quella della Sicilia, è una delle più capienti. A ritrovarla, oggi, la copia con dedica a Genco Russo, se ne farebbe un feticcio del mistero di un’isola affollata di metafore ma affacciandosi dalla finestra di casa in contrada Noce, la residenza di campagna in quel di Racalmuto, Sciascia si conferma nell’agio di chi vive e conosce il mondo.
Padrone di se stesso, degli asparagi selvatici e dello specialissimo genius loci dell’impostura – quella dell’abate Vella raccontato nel suo Consiglio d’Egitto – più di ogni altro posto, lì, lui è Nanà XaXa, così come la traslitterazione in lingua araba impone, svelando quel che il suo volto olivastro e il suo sorriso già annunciano.
Prima dell’avvento dell’Islam, Racalmuto – ovvero Rahal-Maut – neppure esisteva. E lui stesso, presentandosi con la tipica aspirazione delle vocali – che risente del linguaggio saraceno di dodici secoli fa – non sa darsi memoria prima dell’Egira.
Sciascia che viene ben dopo Verga e i suoi vinti – e dopo le lenzuola sporche di morte descritte da Tomasi di Lampedusa – capovolge la disperazione cui si assoggetta la sua terra e adotta la luce e la vita sul lutto. La sua stessa tomba, al cimitero del paese, è abbagliante di chiarore e lumi. Composto nel sepolcro con le mani strette a un crocifisso d’argento reclama con Pascal la possibilità di una scommessa: l’eventualità del Cielo.
La Sicilia spagnolissima che s’invera nella lezione di Giuseppe Antonio Borgese, quella della cupa pasta “cervantina e riberesca”, ovvero la follia onirica del Don Chisciotte di Cervantes e il contrappunto buio nelle pitture di De Ribera, arretra rispetto alla sua scelta di modernità.
Alle tenebre dello Spagnoletto, Sciascia contrappone la luminosa santità delle foto di Ferdinando Scianna che gli consentono di affollare nell’Es la disperante solitudine dei suoi siciliani.
Non c’è libro più erotico di Feste religiose in Sicilia e, dunque, non c’è rave più sensuale della Settimana Santa, con gli scatti di Scianna a confermarlo in un’intensa trama di Eros e sacro. In Morte dell’Inquisitore Sciascia decifra nel sacramento della confessione “una escogitazione, per così dire, boccaccesca”.
Lo stesso celibato dei preti è pura astuzia, assicura invulnerabilità nello sconfinare il mondo della femmina velata, ammantata e addobbata di mantiglie quando svela azioni e intenzioni: “Un modo escogitato da una categoria privilegiata, cioè quella dei preti, per godere di libertà sessuale sul terreno altrui, e nell’atto stesso di censurare una tal libertà nei non privilegiati”.
L’eleganza del lutto estremo – il più potente rito di consacrazione della carne inchiodata – s’avvolge nella brace, tutto sfarzo e fantasticheria, di un desiderio. Gli uomini sono incappucciati. I bambini, pure. E all’hidalgo che se ne va a cavallo del Ronzinante in cerca di Mulini a vento, Sciascia – chiudendo una volta per tutte con Borgese – predilige Giufà, il furbo sciocco di memoria saracena che si tira la porta di casa portandosela sotto braccio al modo di un Magritte assai saputo di cavilli algebrici ancorché limpidi, illogici e umoristici.
Lui, di suo, è un intellettuale i cui occhiali – quelli della letteratura – lo aiutano a decifrare la realtà anche a costo di fraintenderla. Durante i lavori della commissione parlamentare sul terrorismo da deputato si ritrova interrogare Patrizio Peci, il pentito delle Brigate Rosse, e si prepara come se avesse di fronte un testimone del nichilismo travolto dalla miseria, dalla tirannia e dall’ignoranza, con domande tipo “ha letto La Madre, qual è la sua interpretazione di Maksim Gor’kij?”.
Gli altri parlamentari, vicino a lui, sono ammirati del suo candore da Candide. Lui è solo uno che fa sogni in Sicilia – vorrebbe cavarsela con l’optimisme alla Voltaire – ma quelli la sanno lunga e l’avvisano amorevolmente: “Ma che fai, Leonardo? Cosa credi che siano i brigatisti? Tutt’al più avranno letto solo fumetti e giornalini pornografici…”.
E ancora in tema di osé resta da raccontare di quella volta quando a Parigi, nel quartiere a luci rosse di Pigalle, Scianna e Sciascia, inseparabili cercatori di senso, si ritrovano davanti alla locandina di un locale di spogliarelli.
Il fotografo chiede allo scrittore: “Che facciamo, entriamo?”.
“Entriamo” risponde Sciascia.
I due fanno il loro ingresso nel locale deserto. Siedono a un tavolo e subito si palesa davanti a loro una ragazza che sulle note di una musica diffusa da un registratore comincia a spogliarsi.
Scianna guarda furtivamente lo scrittore che, a sua volta, osserva di sottecchi il proprio compagno di disavventura.
Entrambi, imbarazzati, distolgono lo sguardo dalla scena quando finalmente Scianna sussurra a Sciascia: “Che facciamo, usciamo?”.
“Usciamo” borbotta l’altro e quando una volta fuori, camminando per un bel pezzo in silenzio, Sciascia riprende a parlare, dice: “In quel posto, caro amico, l’unica cosa pornografica eravamo noi due”.
(articolo pubblicato su La Lettura del Corriere della Sera) Il 3. gennaio 2021
Eredità e attualità di un modello di scrittura: Leonardo Sciascia
Georges Duby, insigne medievista, tra i maggiori rappresentanti della storiografia sociale francese, rassomigliava i documenti storici alle isolette di un arcipelago sopravvissuto alla scomparsa di un continente sommerso che si pretende di raccontare nella sua interezza [1]. Un’immagine che suggerisce una sconfortante visione della storia e della sua parzialità, palesando la strenua difficoltà di istituire fondate relazioni tra gli sparsi frammenti superstiti e di ricostruire una verità incontrovertibile e assoluta. Questione intricata, che pertiene al metodo storico, ma su cui anche la letteratura, ponendosi sul versante dell’impegno civile, ha spesso steso il proprio sguardo: si pensi al Manzoni della Storia della colonna infame.
Il Novecento letterario italiano ci ha lasciato una delle più alte testimonianze di scrittura votata alla demistificazione, sostenuta da una critica aspra e a tutto tondo rivolta ai tanti, troppi quadri, che la storia ufficiale ha tramandato come inequivocabilmente ricomposti: è il modello di Leonardo Sciascia [2]. Un’eredità importante, da custodire; un patrimonio da tener vivo e trasmettere ai più giovani, di cogente attualità nel tempo presente, popolato di idoli mediatici capaci di conquistare orde di followers nel mondo reale e in quello virtuale, costellato di fake news subdolamente serpeggianti e facilmente destinate a diventare virali, non immune dal pericolo sempre incombente di fascismi di ritorno, di derive politiche pronte a riproporsi «sotto le spoglie più innocenti», come già avvertiva Umberto Eco in uno scritto apparso sul finire del XX secolo, non casualmente ripubblicato lo scorso anno [3].
Sciascia, nato a Racalmuto l’8 gennaio 1921, ci lasciava trent’anni or sono, il 20 novembre 1989, congedandosi con un ultimo, lapidario romanzo giallo, Una storia semplice, ma in verità «complicatissima», data alle stampe da Adelphi nel novembre dello stesso anno [4], e con A futura memoria, raccolta di scritti giornalistici, di taglio politico e civile, che avrebbe visto la luce postuma, nel mese di dicembre, presso Bompiani. Con parentesi scettica al titolo annessa; formidabile, finale boutade di un polemista di razza, maestro nel mescidare ironia e invettiva: se la memoria ha un futuro [5].
 In esergo alla sua ultima prova narrativa, l’intellettuale siciliano inserì una frase di Friedrich Dürrenmatt che, con La promessa, aveva sancito il requiem per il romanzo giallo [6]: «Ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia» [7]. Nell’ultima pagina di Una storia semplice, l’«uomo della Volvo», appena scarcerato, percorre cantando «la strada verso casa»: opera cioè una precisa scelta, la rinuncia consapevole a contribuire all’accertamento della verità. C’è un attimo di esitazione in lui, quando riconosce nel prete, padre Cricco, il «capostazione», o meglio colui che aveva «creduto fosse il capostazione» [8]. Ma, nel gioco degli inganni, l’esitazione è subito vinta dal timore di scontrarsi con i meccanismi di una giustizia incapace di distinguere il reo dall’innocente. Così, in quello che può definirsi il testamento letterario di Sciascia, la verità viene tenuta nascosta, taciuta, come altrove – soggiacendo alle logiche del potere – è stata offuscata, insabbiata, artefatta o imposta, divenendo impostura [9].
In esergo alla sua ultima prova narrativa, l’intellettuale siciliano inserì una frase di Friedrich Dürrenmatt che, con La promessa, aveva sancito il requiem per il romanzo giallo [6]: «Ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia» [7]. Nell’ultima pagina di Una storia semplice, l’«uomo della Volvo», appena scarcerato, percorre cantando «la strada verso casa»: opera cioè una precisa scelta, la rinuncia consapevole a contribuire all’accertamento della verità. C’è un attimo di esitazione in lui, quando riconosce nel prete, padre Cricco, il «capostazione», o meglio colui che aveva «creduto fosse il capostazione» [8]. Ma, nel gioco degli inganni, l’esitazione è subito vinta dal timore di scontrarsi con i meccanismi di una giustizia incapace di distinguere il reo dall’innocente. Così, in quello che può definirsi il testamento letterario di Sciascia, la verità viene tenuta nascosta, taciuta, come altrove – soggiacendo alle logiche del potere – è stata offuscata, insabbiata, artefatta o imposta, divenendo impostura [9].
Come epigrafe di A futura memoria, campeggia invece una citazione da Georges Bernanos: «Preferisco perdere dei lettori, piuttosto che ingannarli» [10]. Nel libro sono riuniti gli interventi più significativi ma anche più discussi dello scrittore di Racalmuto, apparsi tra il 1979 e il 1988 su varie testate giornalistiche, tra cui principalmente “L’Espresso” e il “Corriere della Sera”: da protagonista navigato del dibattito culturale italiano, abituato ad attirare su di sé ripetute critiche e feroci strali, come nel caso della polemica sui professionisti dell’antimafia, anche attraverso quel rimando teneva a ribadire di aver voluto sempre analizzare con fermezza e lucidità la società contemporanea, urlando la sua verità, senza asservimenti, senza timori; e sperava – ma forse era un’estrema provocazione – che le sue pagine potessero essere lette (meglio, rilette) con «serenità» di giudizio, dopo la sua morte [11].
Non semplici omaggi a Dürrenmatt e Bernanos, gli stralci apposti sulle due ultime opere da un lato forniscono utilissime chiavi di lettura per la fruizione delle stesse, dall’altro – combinati fra loro – sembrano offrirsi come cartine di tornasole per la comprensione dell’intero itinerario sciasciano, un universo di scrittura caratterizzato – come recentemente ha ricordato Paolo Squillacioti [12] – da una commistione di soluzioni ed elementi che tende a scardinare le canoniche partizioni riguardanti forme e generi: così, «i romanzi sono ricchi di elementi saggistici, i saggi hanno spesso un andamento narrativo, ed esistono forme letterarie peculiari difficilmente incasellabili fra i generi tradizionali come le cronachette o le inquisizioni alla maniera di Borges» [13].
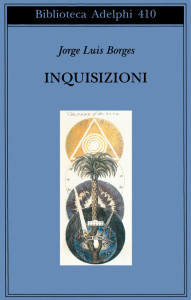 Il pensiero di Borges, un autore che ha influenzato più d’una generazione di intellettuali, da Calvino ad Eco a Tabucchi [14], con la sua concezione della vita e della storia come menzogna e opera contraffatta, viene intercettato e rielaborato da Sciascia, capace di cogliere il senso profondo delle Finzioni e delle Inquisizioni, quella sottile ambiguità di fondo che trasfigura ciascuna pagina in labirinto, ciascuna storia in metafora, aprendo ad una molteplicità di sensi [15]. Come i personaggi di Borges, così anche molti fra i personaggi sciasciani assurgono a simboli: un aspetto che certamente concorre a definire, oggi, trent’anni dopo la sua scomparsa, l’originalità di Sciascia nel panorama letterario italiano e non solo.
Il pensiero di Borges, un autore che ha influenzato più d’una generazione di intellettuali, da Calvino ad Eco a Tabucchi [14], con la sua concezione della vita e della storia come menzogna e opera contraffatta, viene intercettato e rielaborato da Sciascia, capace di cogliere il senso profondo delle Finzioni e delle Inquisizioni, quella sottile ambiguità di fondo che trasfigura ciascuna pagina in labirinto, ciascuna storia in metafora, aprendo ad una molteplicità di sensi [15]. Come i personaggi di Borges, così anche molti fra i personaggi sciasciani assurgono a simboli: un aspetto che certamente concorre a definire, oggi, trent’anni dopo la sua scomparsa, l’originalità di Sciascia nel panorama letterario italiano e non solo.
Tornando ai grandi temi della verità e della giustizia e all’impegno sin dagli esordi ingaggiato dallo scrittore nel provocare il lettore a pensare, può ben affermarsi che tratto costitutivo del suo intender la letteratura sia stata la vocazione ad inoltrarsi nell’oceano oscuro del taciuto, impugnando le armi della ragione e della polemica per trasporre la scrittura – narrativa, saggistica, pamphlettistica – in pervicace inchiesta e inesausta indagine conoscitiva. «Credo nella ragione umana, e nella libertà e nella giustizia che dalla ragione scaturiscono» [16]: questo il credo laico di Sciascia. Correva l’anno 1956 quando, nelle primissime pagine de Le parrocchie di Regalpetra, esprimeva la propria attestazione di fiducia nel razionalismo, posto a fondamento di ogni società che si presuma equa e libertaria: «Ho tentato di raccontare qualcosa della vita di un paese che amo, e spero di aver dato il senso di quanto lontana sia questa vita dalla libertà e dalla giustizia, cioè dalla ragione» [17].
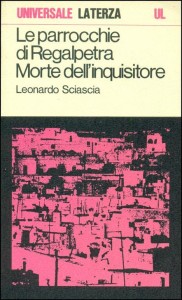 Sin dagli esordi, è la ragione degli oppressi quella che Sciascia, sulla scorta di quel Paolo Luigi Courier che sapeva assestare colpi di penna come fossero come colpi di spada, mostrò di avere a cuore: «La povera gente di questo paese ha una gran fede nella scrittura, dice – basta un colpo di penna – come dicesse – un colpo di spada – e crede che un colpo vibratile ed esatto della penna basti a ristabilire un diritto, a fugare l’ingiustizia e il sopruso» [18]. Dietro l’identificazione tra penna e arma – come ha rilevato Claude Ambroise – occorre scorgere quel sottile «filo etimologico che alla guerra lega la polemica», frutto di «una convergenza ideologica che fa perno sulla Rivoluzione» scoppiata a Parigi il 14 luglio 1789 [19].
Sin dagli esordi, è la ragione degli oppressi quella che Sciascia, sulla scorta di quel Paolo Luigi Courier che sapeva assestare colpi di penna come fossero come colpi di spada, mostrò di avere a cuore: «La povera gente di questo paese ha una gran fede nella scrittura, dice – basta un colpo di penna – come dicesse – un colpo di spada – e crede che un colpo vibratile ed esatto della penna basti a ristabilire un diritto, a fugare l’ingiustizia e il sopruso» [18]. Dietro l’identificazione tra penna e arma – come ha rilevato Claude Ambroise – occorre scorgere quel sottile «filo etimologico che alla guerra lega la polemica», frutto di «una convergenza ideologica che fa perno sulla Rivoluzione» scoppiata a Parigi il 14 luglio 1789 [19].
Una data emblematica per Sciascia che, raccontando Regalpetra, osservava: «è come se la meridiana della Matrice segnasse un’ora del 13 luglio 1789». Per aggiungere subito dopo, con palpabile sconforto: «domani passerà sulla meridiana l’ombra della Rivoluzione francese, poi Napoleone il Risorgimento la rivoluzione russa la Resistenza, chissà quando la meridiana segnerà l’ora di oggi, quella che è per tanti altri uomini nel mondo l’ora giusta» [20].
Chissà se oggi segna l’ora giusta, vien da chiedersi, nel villaggio globale dilaniato da diaframmi sociali sempre più evidenti e allarmanti. La possibilità di leggere, interpretare e proporre, a trent’anni dalla morte di Sciascia, la sua opera in chiave attualizzante inestricabilmente si lega al valore assoluto dall’autore attribuito al recupero e alla trasmissione della memoria [21] e risiede, in ultimo, nel significato universalistico e non localistico della sua indagine conoscitiva, assicurato dall’esser ogni opera – alla maniera di Borges, come visto – specchio di qualcos’altro. Non riduttivo esame analitico della realtà siciliana con le sue particolari categorie antropologiche (uomini, mezz’uomini, ominicchi, pigliainculo, quaquaraquà), giacché quella realtà è assunta a metafora dell’umanità tutta [22].
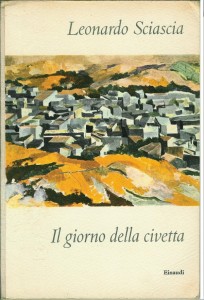 Quel che, nel Giorno della civetta, era detto del Bel Paese («Forse tutta l’Italia va diventando Sicilia»), registrando finalmente l’avvenuta unificazione nazionale, ma sotto il segno della collusione del malaffare [23], oggi potrebbe applicarsi all’Europa: come se la linea della palma fosse salita sempre più a nord, sancendo anche in questo caso una singolare unificazione, oltre Roma, oltre le Alpi, fino a Berlino, Strasburgo, Bruxelles, nel cuore dell’Europa che comanda, al cui interno si è già generata una nuova questione morale e sociale.
Quel che, nel Giorno della civetta, era detto del Bel Paese («Forse tutta l’Italia va diventando Sicilia»), registrando finalmente l’avvenuta unificazione nazionale, ma sotto il segno della collusione del malaffare [23], oggi potrebbe applicarsi all’Europa: come se la linea della palma fosse salita sempre più a nord, sancendo anche in questo caso una singolare unificazione, oltre Roma, oltre le Alpi, fino a Berlino, Strasburgo, Bruxelles, nel cuore dell’Europa che comanda, al cui interno si è già generata una nuova questione morale e sociale.
La divaricazione tra i due poli in perenne opposizione dialettica, quello degli oppressi e degli oppressori, che Sciascia – manzonianamente – ha tratteggiato in tante delle sue opere, è una delle piaghe più evidenti dell’oggi ed è destinata sempre più ad infettarsi, determinando ulteriori diseguaglianze e tensioni.
Chissà cosa ne penserebbe Sciascia di quest’epoca senza ideologie! Chissà cosa direbbe del nostro Mediterraneo, tomba a cielo aperto, uno dei molti teatri del mondo su cui quotidianamente si dispiegano drammi umanitari senza precedenti, soluzioni né consolazioni. Opporrebbe la necessità di una rivoluzione, forse. O forse, affermerebbe ancora – come nell’intervista rilasciata a Marcelle Padovani – che «l’unico modo di essere rivoluzionari, è quello di essere un po’ conservatori», protesi cioè, in una fase storica di inarrestabile disgregazione, a conservare il meglio. Di certo, ci spronerebbe ad indagare, a scrutare, a rigettare l’ovvio, a demolire tutto ciò che ci appare pericolosamente artefatto: «Con molta diffidenza, con tanto scetticismo, ma bisogna vedere» [24].